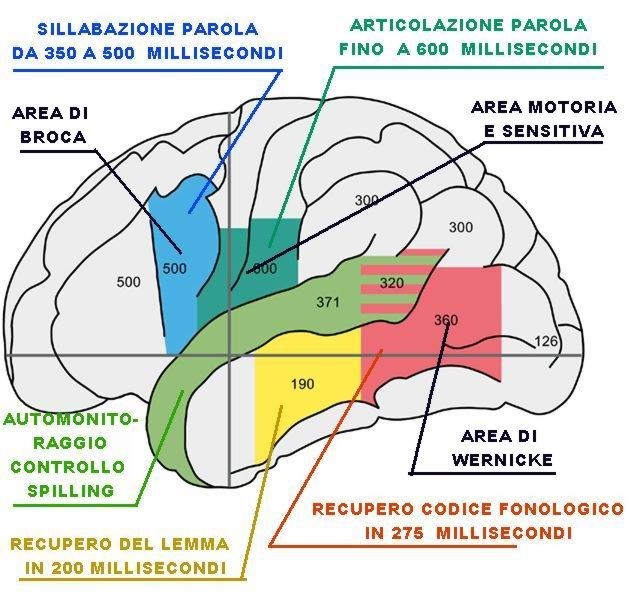Ippocampo, apprendimento e memoria
L'ippocampo è l'area del cervello che comanda il rilascio di ormoni che ci aiutano ad affrontare lo stress: aumentano il battito cardiaco e favoriscono l'adattamento. Ma l'ippocampo è anche centrale in due funzioni fondamentali del cervello: l'apprendimento e la memoria. Un ippocampo più grande si traduce quindi in migliori prestazioni scolastiche.
L'ippocampo nel cervello dei bambini a cui i genitori dedicano maggiori attenzioni è più grande rispetto a quello dei figli meno seguiti. L'intervista a Anna #Oliverio Ferraris: la primissima infanzia è un'età cruciale, ma il cervello continua a modificarsi fino a 20 anni.
I bimbi in età scolare le cui madri li hanno accuditi con affetto nella primissima infanzia, portano i segni visibili di queste attenzioni nel proprio cervello: il loro ippocampo è più grande rispetto a quello dei coetanei. L'ippocampo è un'area del cervello che ha un ruolo cruciale nella memoria e nell'apprendimento, ma anche nella gestione dello stress.
Che il rapporto con i genitori prime fasi di vita del bambino sia cruciale per uno sviluppo emotivo e cognitivo armonioso già si sapeva. Quello che si è riusciti a fare per la prima volta, in uno studio apparso sull'edizione online di Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto da un team di psicologi infantili e neuroscienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis , è quantificare il beneficio sul cervello dei piccoli dell'amore e delle cure ricevute.
#Joan Luby , professore di psichiatria infantile, e i coautori della ricerca hanno prima di tutto dovuto distinguere, in maniera sufficientemente oggettiva, i genitori più affettuosi e attenti da quelli che lo erano meno. Lo studio ha preso le mosse una decina di anni fa, quando Luby e colleghi hanno esaminato le interazioni tra bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, alcuni dei quali con sintomi di depressione o con altri disturbi mentali, e un genitore, quasi sempre la mamma.
Mentre la mamma doveva eseguire un compito il bambino doveva aspettare. Come premio per l'attesa avrebbe potuto aprire un pacco regalo dall'aspetto attraente. La valutazione su quanto e come il genitore fosse in grado di sostenere e confortare il bambino in questa situazione stressante veniva fatta da un gruppo di osservatori esterni che non conosceva nulla né delle condizioni di salute del bambino né del temperamento del genitore.
Anni dopo 92 di quei bambini, ora di età compresa tra 7 e 10 anni, sono stati sottoposti a una tac cerebrale, che consente di avere un'immagine chiara del cervello e di misurare la grandezza dell'ippocampo. Quello che è emerso è che i bambini che non avevano sofferto di forme depressive e che erano allevati con maggiori attenzioni avevano un ippocampo del 10% più grande rispetto ai figli di madri meno affettuose.
Secondo Luby mentre nei bambini depressi era atteso un risultato del genere, perché il volume dell'ippocampo risulta più piccolo anche negli adulti con depressione, la vera sorpresa è nella differenza riscontrata tra bambini sani e legata esclusivamente alle cure parentali.
Perché questo risultato è così importante?
L'ippocampo è l'area del cervello che comanda il rilascio di ormoni che ci aiutano ad affrontare lo stress: aumentano il battito cardiaco e favoriscono l'adattamento. Ma l'ippocampo è anche centrale in due funzioni fondamentali del cervello: l'apprendimento e la memoria. Un ippocampo più grande si traduce quindi in migliori prestazioni scolastiche.
Cosa deve fare un genitore per assicurare al proprio figlio lo sviluppo migliore?
Come si declina, insomma, questa affettività che sembra essere così importante per lo sviluppo cerebrale del bambino? Risponde Anna Oliverio Ferraris , docente di Psicologia Evolutiva all'Università La Sapienza di Roma.
Ci sono altri studi recenti che dimostrano che i bambini maltrattati hanno un funzionamento cerebrale diverso, che può avere effetti anche in adolescenza. Mi pare che questa ricerca vada nella stessa direzione. L'età prescolare è cruciale certo, ma non solo nel rapporto del bambino con la mamma, bensì con tutte le persone che stanno intorno al bambino e lo accudiscono: madre, padre, i nonni.
Cosa devono garantirgli queste figure?
Quello di cui un bambino ha bisogno: un clima caldo, affettivo, stimolante, partecipativo, dove il bambino sente che è importante per chi sta intorno a lui. Via via che cresce bisogna rispondere alle sue domande, dargli ascolto. Ma attenzione a evitare l'iperprotezione e, ovviamente, ogni forma di maltrattamento.
La violenza ma anche l'indifferenza?
Esistono forme più o meno gravi di maltrattamento, dirette o indirette. La violenza tra genitori è una forma di maltrattmento indiretta che mette il bambino in uno stato di allerta, lo spinge a non fidarsi degli adulti che lo circondano. Ma anche la trascuratezza è una forma di maltrattamento: abbandonare un bambino tre ore al giorno di fronte al televisore, per esempio. Un bambino ha bisogno di fare esperienze di prima mano, di muoversi, di giocare, il gioco è la sua vita e la sua terapia. La carenza di giochi spontanei e di movimento che caratterizza molti bambini di oggi, che fanno una vita troppo sedentaria, è una forma di trascuratezza dell'intera società.
Altri comportamenti da evitare?
Dobbiamo ricordarci che i bambini non sono adulti in miniatura. Il genitore che non gli parla, che va sempre di fretta e si limita risolvere i problemi pratici ma non ha momenti per starci insieme, raccontargli delle storie, commette un errore. Quando i bambini sono piccoli bisogna trovare il tempo. Se una madre lavora è bene che ci sia anche un padre accudente, che dedichi del tempo al bambino.
Altre figure, come la baby sitter, non possono avere un ruolo?
Certo, ma siccome la mamma e il papà fanno comunque parte della sua vita, il bambino ha bisogno di sentire la loro attenzione perché lo valorizza e lo fa sentire importante rispetto agli altri. Il bambino sa di esser debole nei confronti della società, ma se è amato si sente forte.
E con i capricci come la mettiamo?
A volte per paura di sembrare indifferenti i genitori rischiano l'opposto: cedere su tutto.
Oltre all'affetto è altettanto importante che ci siano regole e coerenza, ai bambini fa molto bene la routine. Vanno soddisfatti i bisogni fondamentali: affetto, calore, cibo. I desideri possono essere soddisfatti qualche volta o rimandati nel tempo. Il bambino se c'è il clima giusto lo accetta. Magari protesta di fronte a certe regole ma gli dà sicurezza sentire che i genitori sanno cosa è bene per lui e sono coerenti.
Fino a che età le cure dei genitori hanno un effetto diretto sullo sviluppo dei figli?
Il cervello continua a crescere fino a 20 anni, probabilmente un recupero è sempre possibile, perché per tutto questo tempo c'è molta plasticità, il cervello è ancora suscettibile di cambiamenti.